OPERA OMNIA
Musica vocale:
tra rito e narrazione
La produzione vocale di Daniele Maffeis si muove con naturalezza tra sacro e profano. Le composizioni liturgiche – Messe, mottetti, introiti – si ispirano alla riforma ceciliana, ma senza imitazioni pedisseque del passato: accanto alla sapienza contrappuntistica, si affacciano sensibilità armoniche moderne, sempre pensate per un ascolto comprensibile e partecipato. Anche nei brani devozionali in italiano, spesso scritti per voci e strumenti, resta forte la volontà di offrire musica accessibile e mai banale.
Sul versante profano, spiccano tre opere liriche che attraversano diversi generi – dalla farsa al dramma sacro – e una serie di operette didattiche per ragazzi, dove racconto e musica si intrecciano con leggerezza. Non mancano le liriche da camera, scritte su testi anche dialettali, che restituiscono uno spaccato intimo del panorama letterario italiano del tempo.

Musica strumentale:
eleganza e invenzione
Un terzo dell’opera di Maffeis è dedicato alla musica strumentale. L’organo, suo strumento d’elezione, ricorre più nelle improvvisazioni dal vivo che nei lavori scritti, ma resta centrale nell’ispirazione generale. Le composizioni per strumento solo – pianoforte o organo – convivono con lavori cameristici più articolati, scritti per piccoli ensemble o per duo con violino, trombone o pianoforte a quattro mani.
Nelle partiture orchestrali, spesso legate a soggetti religiosi o poetici, emerge la vocazione narrativa del compositore. Alcuni brani, come il ciclo di variazioni su un tema tratto dall’opera Le tre notti di luce, mostrano una raffinata costruzione formale, accanto a un gusto descrittivo che sfiora la musica a programma.
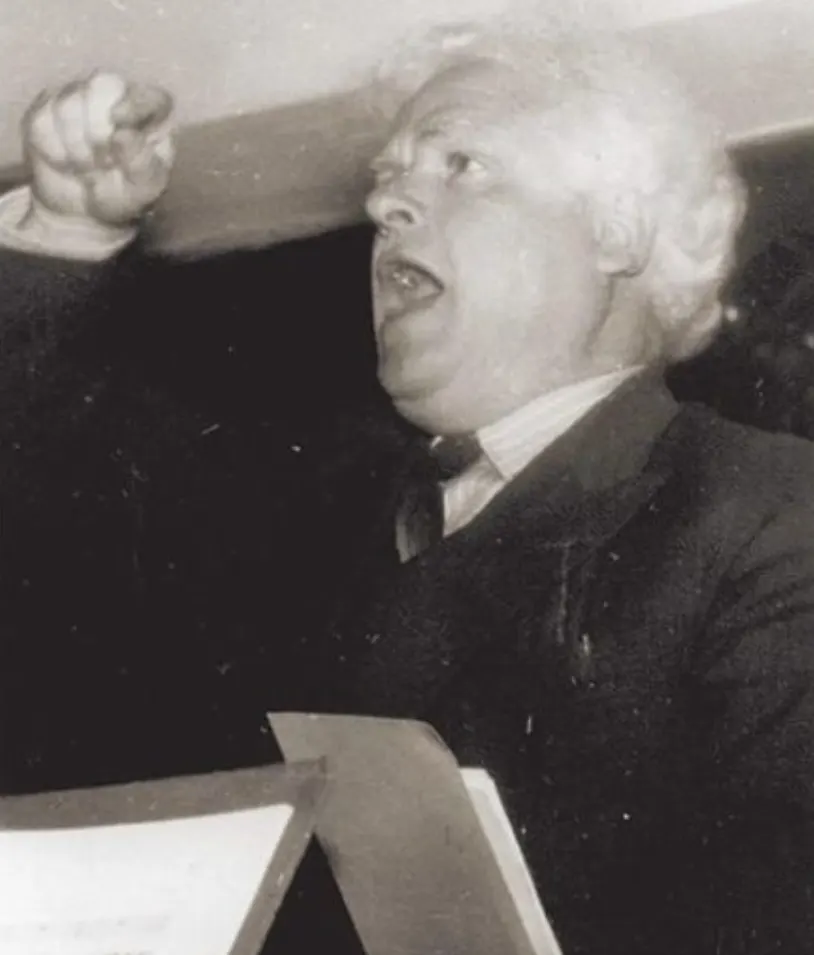
OPERA OMNIA
VOLUME 1: LIRICHE, CORI, CANZONI
La produzione vocale profana d’ambito cameristico di Daniele Maffeis non è ampia: vi figurano brani legati ad occasioni celebrative per istituzioni religiose o scolastiche, liriche spesso dedicate agli autori dei testi italiani o dialettali, brani polifonici a cappella di impostazione madrigalistica. Nelle linee vocali è palese l’influsso esercitato dalla generazione post pucciniana affermatasi intorno agli anni ’30 del Novecento, che a Milano trovò un ambiente particolarmente ricettivo. Il volume è diviso in due tomi: nel primo figurano i brani a cappella o con accompagnamento pianistico, mentre il secondo contiene quattro brani per voce e orchestra, tre dei quali derivano da originali con pianoforte, e una versione della Barcarola che differisce da quella presente nel Cantore danese.
VOLUME 2: PIANOFORTE
A 2 e a 4 mani
Nel volume sono raccolti quattordici brani per pianoforte e una raccolta di cinque brevi pezzi a quattro mani. Le composizioni originali nel primo gruppo sono solo cinque, ma anche i restanti brani vanno intesi come ‘originali’ nel senso che offrono in genere la prima stesura, e non la riduzione a posteriori, di composizioni affidate poi all’orchestra. In un caso poi, le 10 Variazioni sul ‘Corale’ dell’opera “Le tre notti di luce”, si tratta di una effettiva rielaborazione per l’esecuzione concertistica. Il ciclo a quattro mani, di semplice esecuzione, aggiunge un gustoso capitolo alle musiche ispirate o destinate al mondo dell’infanzia.
A DUE MANI
– SONATA IN DO MINORE
– SONATA IN DO MAGGIORE
– SAN FELICE AL LAGO
– SUITE SCHILPARIESE
– CANTO D’AMORE
– BARCAROLA
– GAVOTTA
– INTERMEZZO LIRICI
– CAPO D’ANNO
– MEDITAZIONE
– PRELUDIO – CORALE – FUGA
– 10 VARIAZIONI SUL CORALE
– BERNADETTE
– FANTONIANA
A QUATTRO MANI
– GIOCATTOLI DI UNA BAMBINA
– SUL SENTIERO VERSO L’ASILO
– IL GOBBETTO PORTAFORTUNA
– LA MOTOCICLETTINA
– IL NIDO ONDEGGIANTE
– IL PICCOLO ANNAFFIATOIO ROSSO
VOLUME 3: MUSICA DA CAMERA E CONCERTANTE
La pubblicazione è divisa in due tomi: nel primo si trovano composizioni per uno strumento (in un caso due) e pianoforte, nel secondo alcune versioni con orchestra e un brano originale per archi. Vi figurano accostamenti tradizionali (violino e pianoforte, con tre Sonate e un breve ‘poema’), e più singolari scelte strumentali per pagine dall’impianto concertante affidate di volta in volta a flauto, due clarinetti, cornetta o tromba, trombone, contrabbasso (eventualmente sostituito da fagotto o violoncello). Si tratta perciò anche di un’interessante integrazione al repertorio solistico per quegli strumenti poco considerati dai compositori al di là del loro impiego orchestrale.
VOLUME 4: ORGANO
Opere per Organo
L’opera organistica di Daniele Maffeis offre all’esecutore uno dei profili più interessanti e significativi del musicista, che fece dell’organo il proprio strumento d’elezione come stimato docente e interprete, in particolare nell’arte dell’improvvisazione. Forse per questo motivo i brani rimasti sono in numero piuttosto limitato, sufficiente tuttavia a palesare le peculiarità compositive, a cominciare dalla ricercatezza armonica e da un virtuosismo funzionale agli spiriti, anche bizzarri, della pagina. Anche in questo volume compaiono brani reperibili anche in versione orchestrale: a differenza di quanto accade in genere col pianoforte si tratta di versioni per l’esecuzione, non di stesure preliminari.
MEDITAZIONE – in lab maggiore
ANDANTE PER ORGANO
ANTIPHONAE MAJORES – dalla liturgia dell’Avvento
CAPRICCIO E CANNONE – in sol minore
CORALE – in mi minore
INTROITO – (per) Pasqua
OFFERTORIO – (per) Pasqua
PICCOLA PASTORALE
PRELUDIO FANTASTICO E FUGA
SPIRITELLI DELL’ORGANO – pezzo caratteristico
TRIONFALE “ADVENIANT REGNUM TUUM” – in lab maggiore
FANTONIANA – in tre movimenti
SYMPHONICUM NOVA ET VETERA – Litanie
SONATA POUR ORGUE – en do majeur
VOLUME 5: MESSE
A 1 e più voci eguali e miste, in latino e organo
Sono qui raccolte le sei Messe complete per voci (da una a quattro) e organo, una delle quali presente in duplice versione. In queste composizioni sono evidenti gli originali connotati che le rendono particolarmente adatte all’accompagnamento del rito sacro: una struttura formale semplice e concisa anche per il Gloria e il Credo con una libera successione delle frasi volta maggiormente a evidenziare il significato emotivo o concettuale di ciascun passo, piuttosto che a creare artificiosamente una forma prestabilita.
MESSA POPOLARE IN ITALIANO – per una voce media e organo
MESSA POPOLARE – ad una voce media. “Che il popolo preghi”
MISSA DANIEL PROPHETA – a due voci dispari con organo
MESSA SOLENNA “REGINA ORDINIS MINORUM” – a due voci eguali e organo.
MESSA “MARIAE NASCENTI” – a tre voci miste e organo
MISSA REGINA PACIS – a tre voci pari con organo
MISSA REGINA PACIS – a quattro voci dispari e organo
VOLUME 6: CORI E POEMI RELIGIOSI
Al di fuori dell’ambito liturgico Daniele Maffeis scrisse alcuni brani di carattere ‘sacrosinfonico’; nel primo tomo troviamo due ampi lavori corali con orchestra, un inno per coro unisono e banda e altre quattro partiture in cui le voci sono accompagnate da un gruppo strumentale, mentre nel tomo secondo trovano posto i brani col solo accompagnamento di organo o pianoforte. Caso particolare la visione musicale in un atto “Vestita di sole”, la cui stesura pianistica rimanda dichiaratamente a una versione orchestrale di cui non s’è trovata traccia.
VOLUME 7: BRANI SACRI
A 1 e più voci eguali e miste e organo
Si tratta di quasi un centinaio di composizioni di breve o brevissima dimensione; le dediche e le datazioni consentono di ripercorrere l’intero ciclo creativo dell’autore.
Meno numerosi i brani a cappella rispetto a quelli con organo, impegnato sia nel ruolo di semplice accompagnamento che di anticipazione o amplificazione della tematica vocale. Accanto a semplici brani destinati al canto dell’assemblea troviamo anche composizioni decisamente più impegnative, anche per l’arditezza di alcune soluzioni armoniche adottate.
> BRANI A UNA VOCE
> BRANI A DUE VOCI
> BRANI A TRE VOCI
> BRANI A QUATTRO E CINQUE VOCI
> APPENDICE
VOLUME 8: COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA
I quattro tomi in cui è diviso il volume accolgono le composizioni orchestrali con organico più ampio, per molti dei quali la scelta della libera forma del poema sinfonico si può leggere come naturale conseguenza della pratica improvvisativa organistica.
Nel primo si trova Fantoniana, poema sinfonico in tre movimenti ispirato alle sculture lignee di Andrea Fantoni, nel secondo Simphonicum nova et vetera, orchestrazione di un brano organistico nato per accompagnare la visione di alcuni dipinti di Ernesto Bergagna ispirati alle litanie mariane; nel terzo troviamo una composizione della maturità, le 10 variazioni per orchestra (vedi vol. II) e il Preludio corale e fuga scritto durante gli studi al Conservatorio di Milano; il quarto comprende tre brani, Sella in Valsugana, Bernadette, Capodanno, reperibili anche nei voll. II e IV e la riproduzione anastatica della prima stesura di un brano, Dei sepolcri (ispirato al carme foscoliano), abbozzo di poema sinfonico mai orchestrato.
VOLUME 9: OPERE LIRICHE: ANTHY
Dramma lirico in tre Atti – Cinque Quadri
Il dramma lirico in tre atti “Anthy”, ultima cronologicamente delle tre opere di Maffeis essendo stata completata nel 1937, ha per fonte l’omonimo romanzo di Guido Milanesi, prolifico e popolare autore di romanzi di avventure marinare ambientati spesso sulle coste orientali e meridionali del Mediterraneo. L’opera mette in scena l’amore destinato a un tragico destino tra una ragazza greca e un tenente di vascello italiano a Rodi durante il conflitto italo-turco; cori e brani d’ambiente militareschi od orientaleggianti incorniciano la vicenda. Il volume è diviso in quattro fascicoli, uno per ciascun atto della partitura orchestrale e uno per lo spartito completo, realizzato anche quest’ultimo dall’autore, come anche per tutti gli altri lavori teatrali. In ciascun fascicolo il testo del libretto precede la partitura musicale.
VOLUME 10: OPERE LIRICHE: IL MAESTRO SMANIA
Commedia in un Atto
La commedia in un atto “Il Maestro Smania” musica un libretto di Antonio Ghislanzoni già utilizzato alla fine del sec. XIX da un altro compositore bergamasco, Cesare Clandestini. L’opera, completata nel 1930, fu presentata nel 1963 al concorso organizzato a Lecco in occasione dei settant’anni della scomparsa del librettista, giudicata positivamente, ma non rappresentata per insorte difficoltà di allestimento (si ripiegò allora sui “Promessi sposi” di Petrella); nel centenario della nascita del compositore fu invece eseguita, seppur in forma di concerto, al teatro ‘Donizetti’ di Bergamo. La partitura prevede tre voci soliste senza coro; il riferimento a Falstaff e Gianni Schicchi è inevitabile, stimolando a un discorso dal passo deciso, senza inutili indugi lirici. Il testo musicale è pubblicato in due fascicoli separati, partitura e spartito.
VOLUME 11: OPERE LIRICHE: LE TRE NOTTI DI LUCE
Opera Lirica in tre Atti e due Quadri
Nel terzo decennio del Novecento sono concentrati gli sforzi di Daniele Maffeis per affermarsi sul palcoscenico operistico. Dopo “Il Maestro Smania”, dagli incontri con Giovanni Mari, docente di lettere per un quarantennio al liceo scientifico di Milano, nasce il progetto teatrale più ambizioso del compositore gazzanighese, che mette in scena la conversione di Jacopone da Todi. Si tratta di un oratorio scenico, in cui ha un grande rilievo la parte corale, con un motivo ricorrente rielaborato in anni successivi in un ciclo di variazioni (voll. II e VIII). Come afferma nella premessa l’autore del testo, «il libretto contiene, in tre notti, una storia e due Sequenze; la vera storia esaurisce quasi sè stessa nella notte prima, in modo che le Sequenze siano, al possibile, sostenute dalla musica sola: una musica la quale sappia unire e fondere sinfonismo e teatro». L’edizione prevede tre fascicoli per la partitura di ciascun atto e un fascicolo per l’intero spartito.
VOLUME 12: OPERETTE: IL CANTORE DANESE
Operetta in tre atti
Poco prima del secondo conflitto mondiale Maffeis conosce mons. Ambrogio Palestra, che lo induce a scrivere su propri testi sei operette didattico-ricreative per l’oratorio di Abbiategrasso, che vedranno la luce tra il 1937 e il 1951 e che verranno più volte replicate durante la vita del compositore. In tutti questi lavori l’obbligo alla facilità di scrittura non risulta costrittivo, dato che la semplicità melodica e l’ambito vocale adatto a voci di ragazzi consente comunque una variata tavolozza espressiva per dar vita alle differenti situazioni della vicenda. “Il cantore danese” è stato composto nel 1945 e nel gruppo dei sei lavori è quello di più ampie dimensioni; si ispira al poema epico medioevale “Gudruna”, scritto nel XII secolo e ispirato alle gesta marinaresche dei Vichinghi. L’apprezzamento raccolto dall’operetta è testimoniato dal riutilizzo di alcuni suoi momenti come brano isolato (vedi i voll. I, II, III e IV). La pubblicazione, come per tutte le altre operette, consta di due fascicoli, partitura e spartito.
VOLUME 13: OPERETTE: IL FLAUTO DEL RE
Operetta in tre atti
Ispirata alle vicende biografiche di Federico II di Prussia, l’operetta ha visto la luce nel 1942. Oltre alle voci soliste e corali un ruolo importante è svolto naturalmente dal flauto, lo strumento d’elezione del re come del giovane protagonista, che salverà il monarca da una congiura di palazzo. Le recensioni dell’epoca sottolineavano come lo spettacolo fosse essenzialmente diverso dalle ‘solite operette’ vicine al genere del varietà e alla musica di consumo; al contrario veniva apprezzato l’impegno dei due autori per dare al teatro degli oratori testi degni della loro missione educativa.
VOLUME 14: OPERETTE: IL GATTO CON GLI STIVALI
Operetta in tre atti
Definita come ‘favola allegra in tre tempi’, prende spunto dall’omonima fiaba di Charles Perrault. Composta alla fine del 1950, l’operetta ebbe la sorte di numerose esecuzioni in varie località lombarde, sia per il soggetto adattissimo all’intento di educare dilettando, sia per l’organico flessibile, che poteva essere limitato al quintetto d’archi e al pianoforte, quest’ultimo anche con una scrittura di un certo impegno, non volta al semplice accompagnamento.
VOLUME 15: OPERETTE: I MORTULAGHI
Operetta in tre atti
Alcune delle operette di Ambrogio Palestra hanno argomento storico, anche se le situazioni reali vengono arricchite con particolari di fantasia. “I Mortulaghi” sono
i morti delle varie guerre di insurrezione della Corsica che, secondo la leggenda, apparivano sotto forma di fantasmi invocati in momenti drammatici dagli abitanti
dell’isola. L’operetta ha per sottotitolo “La canzone della Patria – Scene patriottiche in tre atti”; scritta negli anni del secondo conflitto mondiale, non fu mai rappresentata, probabilmente anche per l’argomento, legato a vicende poco conosciute e troppo diverso, nel suo tono di esaltazione patriottica, dallo spirito degli altri lavori. Anche la partitura orchestrale presenta una scrittura più impegnativa rispetto al consueto.
VOLUME 16: OPERETTE: IL PELLEGRINO BIANCO
Leggenda Natalizia – Atto Unico
La “leggenda natalizia in un atto” è cronologicamente il primo frutto della collaborazione tra Maffeis e don Palestra, scritta nel 1937 e rappresentata la prima volta il giorno di Natale di quell’anno. Ispirata al teatro allegorico medievale mette in scena il contrasto tra il pellegrino bianco e il pellegrino nero, sotto le cui vesti si celano l’Arcangelo Gabriele e Satana. La scena terza del breve lavoro è stata poi adattata come secondo movimento dei Tre momenti per trombone e pianoforte (vol. III).
VOLUME 17: OPERETTE: I TRE FANCIULLI NELLA FORNACE ARDENTE
Operetta in tre atti
È la seconda operetta in ordine cronologico, eseguita la prima volta il 26 novembre 1939 ad Abbiategrasso e più volte replicata. Ambrogio Palestra, autore del testo, scrive che «fu infatti rappresentata in luoghi diversi e noi avemmo la soddisfazione di vedere con certezza d’aver compiuto un’opera di apostolato». Il libretto inscena il noto episodio narrato nel Libro del profeta Daniele dei tre fanciulli condannati ad essere arsi nella fornace e salvati miracolosamente da un angelo. Al pari del Cantore danese si tratta del lavoro più sviluppato musicalmente e scenicamente; anche da questa partitura Maffeis ha riutilizzato alcune pagine, in particolare la Preghiera è divenuta il secondo tempo dei Tre momenti per flauto e pianoforte o archi (Vol. III).
VOLUME 18: MIMI: LA MADRE E I SACRAMENTI
Il mimo sacro (un’azione basata solo sul gesto, senza un testo narrativo), soggetto di Eva Tea e mimografi a di Emma Baldo, è stato composto nel 1957 in tre versioni, ciascuna pubblicata in un tomo, per coro con accompagnamento rispettivamente di pianoforte e armonium, piccola e grande orchestra (quest’ultima incompleta, priva degli ultimi due Sacramenti). I sette sacramenti simboleggiano le tappe di una vita sempre combattuta tra Bene e Male. Ciascun tomo contiene, prima della partitura musicale, la dettagliata descrizione dei costumi e dei movimenti necessari per la realizzazione scenica dell’opera. Il coro interviene solo all’inizio per intonare, in italiano il ‘Padre nostro’.