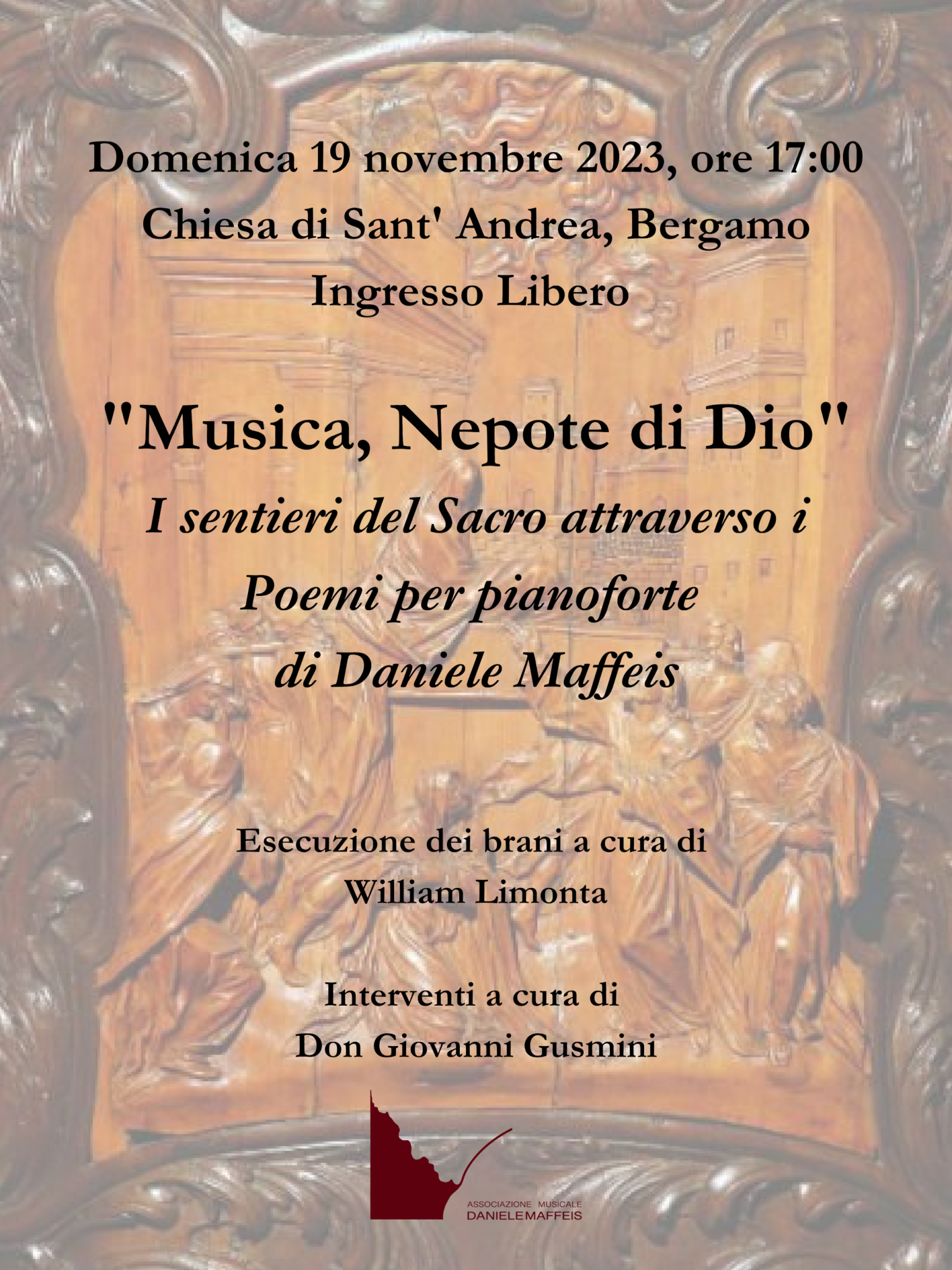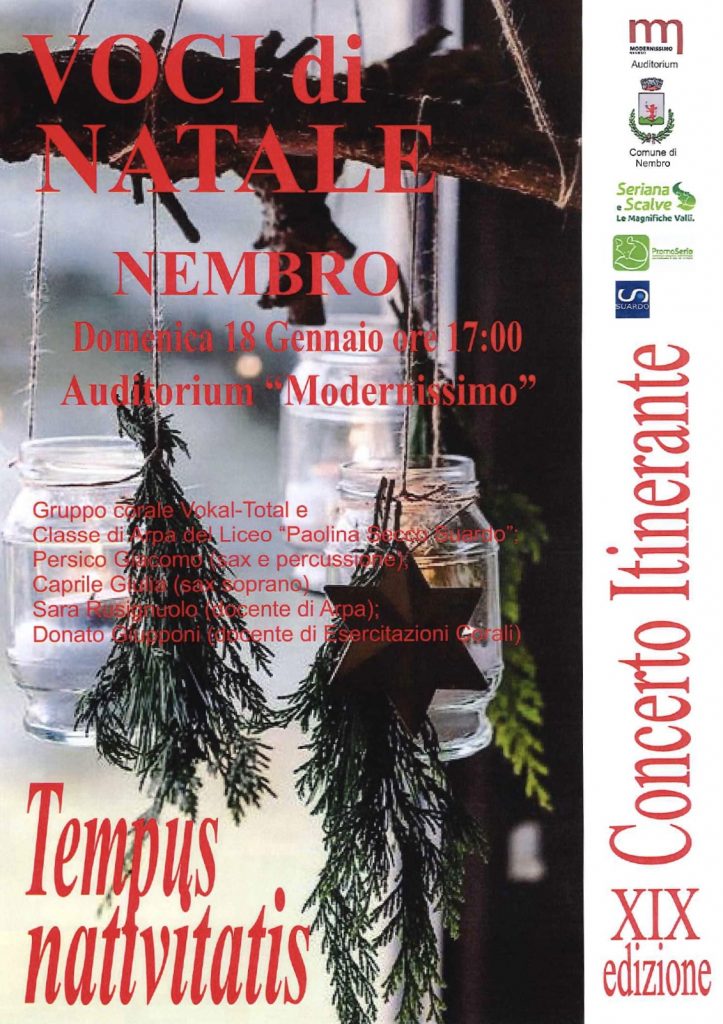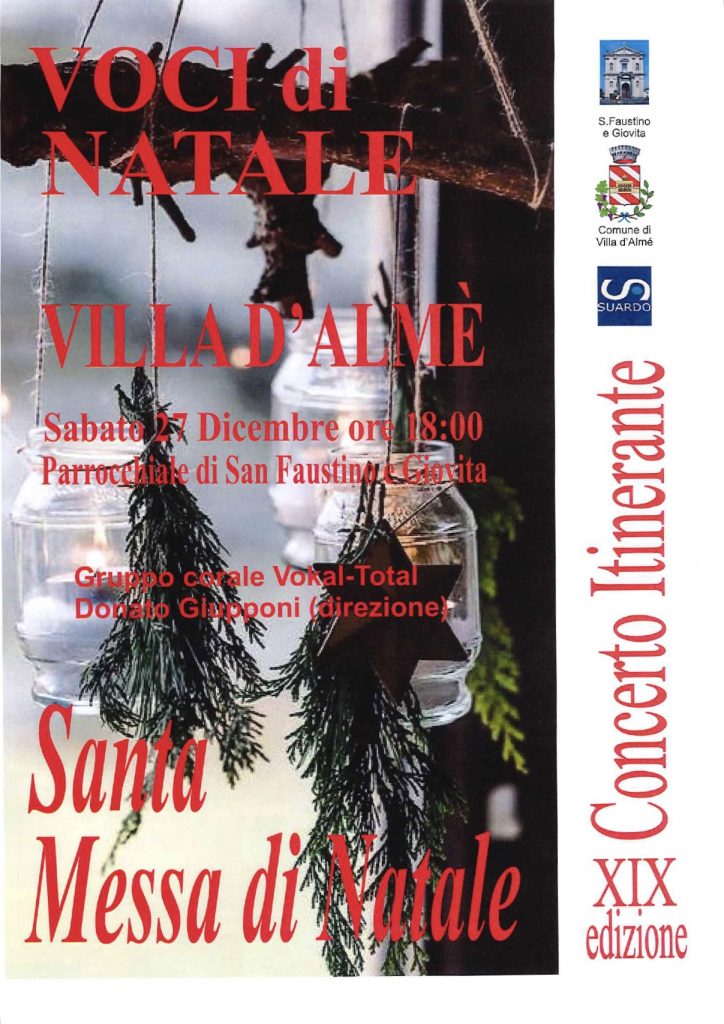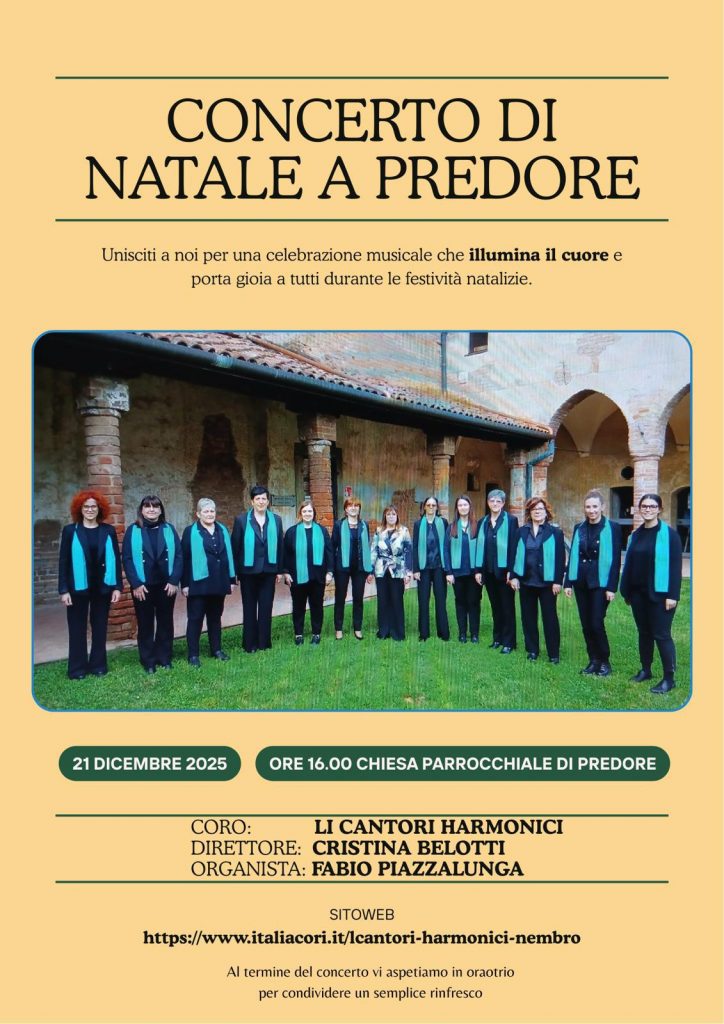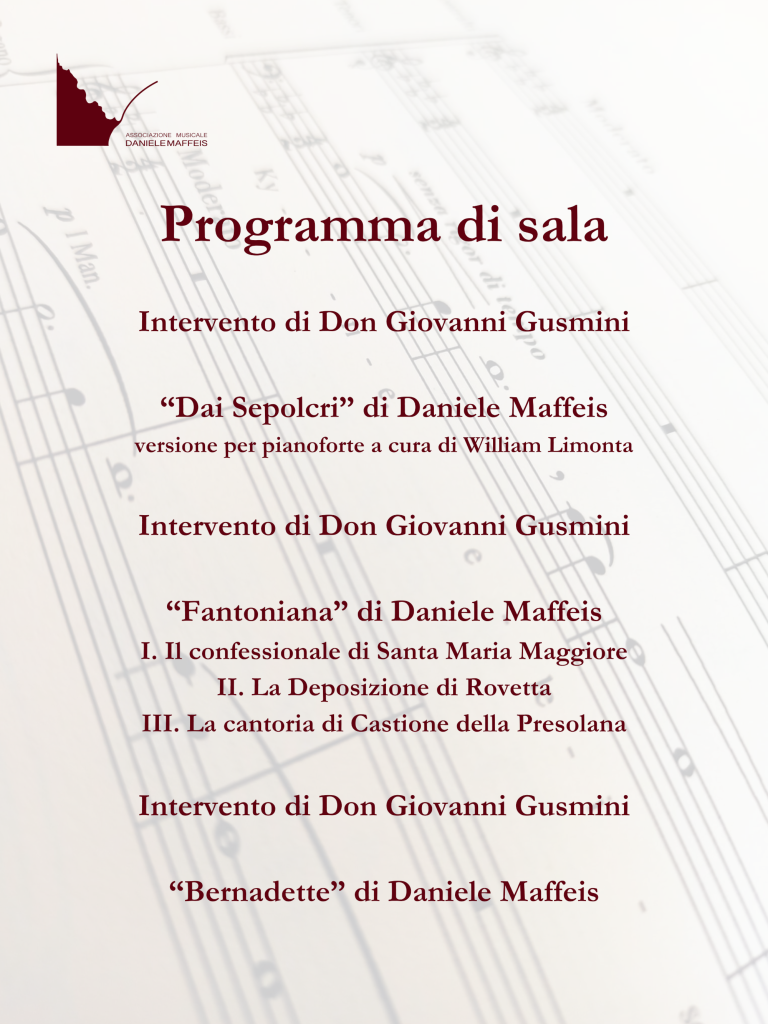
Ugo Foscolo, Il carme dei sepolcri (1806-1807).
Mentre si trovava a Treviso, ospite in Villa Franchetti di Isabella Teotochi Albrizzi, e a Brescia, ospite in Palazzo Martinengo della contessa Marzia Martinengo Provaglio, Ugo Foscolo aveva attivamente partecipato alle vivaci discussioni seguite all’estensione al Regno d’Italia, avvenuta il 5 settembre (pubblicato il 3 ottobre) del 1806, dell’Editto di Saint-Cloud, che era stato emanato da Napoleone già nel giugno del 1804. Tale editto non solo imponeva che i cimiteri dovessero traslocare fuori città, in luoghi arieggiati e soleggiati, ma anche che le tombe dovessero essere tutte uguali e senza iscrizioni. Solo per i defunti illustri un’apposita commissione avrebbe stabilito se fosse il caso di apporre alle loro sepolture degli epitaffi (un po’ come si fa oggi, onorando alcuni defunti illustri di una lapide nel Famedio dei Cimiteri monumentali, come si fa a Bergamo e a Milano). Un tema, questo, che era già stato meditato ed espresso dai poeti preromantici inglesi, come Thomas Gray (Elegy written in a Country Churchyard, 1751) e Edward Young (Night Thoughts, 1742). A Bergamo, ad esempio, questo portò alla creazione dei cimiteri di Santa Lucia (chiuso rapidamente e trasferito presso San Giorgio alla Malpensata), di Valtesse, di San Maurizio (in zona San Fermo): inglobando quest’ultimo, tra il 1896 e il 1913 fu costruito l’attuale Cimitero monumentale su disegno dell’Ing. Ernesto Pirovano.
Per la sua composizione, datata “aprile 1964”, Daniele Maffeis trae ispirazione dai versi che riporta sul manoscritto (vv. 1-3a; vv. 201b-212): sono i tre versi con i quali si apre il poema epistolare dedicato dall’autore all’amico Ippolito Pindemonte, cui seguono dieci versi nei quali Foscolo rievoca l’esperienza di un navigatore che, passando al largo delle isole greche, avesse visto – o immaginato – le epiche battaglie consumate su quelle terre ai tempi cantati da Omero. Questo detta a Maffeis l’occasione di mettere in musica un’esperienza analoga, secondo lo stile di una delle sue barcarolle.
«All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne
Confortate di pianto è forse il sonno
Della morte men duro? …
[…]
… Il navigante
Che veleggiò quel mar sotto l’Eubea,
Vedea per l’ampia oscurità scintille
Balenar d’elmi e di cozzanti brandi,
Fumar le pire igneo vapor, corrusche
D’armi ferree vedea larve guerriere
Cercar la pugna; e all’orror de’ notturni
Silenzi si spandea lungo ne’ campi
Di falangi un tumulto e un suon di tube
E un incalzar di cavalli accorrenti
Scalpitanti su gli elmi a’ moribondi,
E pianto, ed inni, e delle Parche il canto».
Parafrasi:
… Il navigante che attraversò quel mare, costeggiando l’isola di Eubea, vedeva attraverso l’immensa oscurità un balenio d’elmi e di spade cozzanti, vedeva i roghi funebri mandar fuori fuoco e vapore, vedeva scintillanti armi di ferro e fantasmi di guerrieri cercare la battaglia; e fra l’orrore della notte silenziosa si diffondeva nei campi il tumulto delle schiere combattenti, il suono delle trombe e l’incalzare dei cavalli che accorrevano scalpitanti sugli elmi dei moribondi, il loro pianto, e i canti dei vincitori, e quello delle Parche.
Il Confessionale di Santa Maria Maggiore (1705)
Andrea Fantoni (Rovetta, 1659–1734). Commissionato nel 1704 dal canonico Pietro Mazza per il Vescovo Luigi Ruzzini il confessionale viene eseguito da Andrea Fantoni e consegnato il 25 marzo 1705. Divenne il confessionale del Canonico Penitenziere. Rimase in Duomo poco tempo e fu poi donato alla Parrocchia di Zandobbio. Portato in Santa Maria Maggiore per una mostra nel 1898 fu acquistato dalla Misericordia Maggiore.
Il Confessionale narra attraverso figure a tutto tondo in legno di noce e formelle a bassorilievo in legno di bosso la teologia del sacramento della Penitenzia, sia dal punto di vista del confessore sia dal punto di vista del penitente. Al primo le persone della Trinità e l’episodio della consegna delle chiavi da parte di Gesù a Pietro ricordano l’origine della grazia che nel Sacramento si amministra, mentre l’immagine della risurrezione del figlio della vedova di Nain, che campeggia al centro dello sportello, mostra l’effetto che tale grazia sortisce, ossia il rinascere del peccatore perdonato a vita nuova. Ancora, figure allegoriche illustrano le virtù che il confessore è chiamato ad esercitare, come la prudenza, la sapienza, la mitezza, la custodia del segreto, mentre quelle cui è chiamato il penitente sono raffigurate in modo evidente dalle figure che incorniciano l’accesso al confessionale stesso: la contrizione e il disprezzo del mondo. Mentre esercita il proprio ministero, il confessore può contemplare le allegorie della misericordia e della giustizia effigiate sulle antelle. A propria volta, i penitenti che ai due lati del confessionale attendono il proprio turno possono meditare da un lato sulla flagellazione di Gesù e dall’altro sulla sua Deposizione, mentre poco sopra danno il buon esempio da un lato santa Margherita da Cortona e, dall’altro, santa Maria Maddalena.
La contemplazione di questo capolavoro di scultura e teologia suscitò in Daniele Maffeis i sentimenti che egli espresse in un articolo apparso sul Giopì il 3 novembre 1963, commentando con lo pseudonimo DAMA, la propria composizione recentemente eseguita la sera dell’inaugurazione del Salone-teatro “Mobile lignum”: «l’Autore ha voluto descrivere, e vi è riuscito secondo il nostro parere, lo stato d’animo che, pervaso di sentimenti contrastanti, prova la persona davanti al Confessionale che si trova nella Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo. La statua del Rispetto Umano [il Disprezzo del mondo] che si crede, a ragione, la parte più significativa del capolavoro. Il musicista ha descritto con tema di ritmo saltellante la insinuazione di Satana che serpeggia ovunque, seduce e ingrandisce. Ma da questo punto nasce la preghiera del penitente a Colui che tutto può e perdona. La preghiera che si sviluppa alla sua volta, su tutta la gamma orchestrale, la lotta è feroce, ma non tarda la vittoria sfolgorante, maestosa a prorompere dal corale di tutti gli ottoni, mentre l’orchestra tutta esalta festosamente la vittoria del bene sul male».
Il Compianto sul Cristo Morto di Clusone (1726 [il Cristo] – 1742 [le altre statue]).
Andrea Fantoni (Rovetta, 1659–1734). Questo Compianto fu realizzato successivamente a quello di Rovetta (1699-1711). Entrambi sono conservati presso gli Oratori dei Disciplini di queste due parrocchie, anche se quello di Clusone vi venne collocato soltanto nel 1905, dopo che la Fabbriceria parrocchiale ne decise la traslazione da un altro ambiente ritenuto inadatto, che sorgeva a fianco.
La tradizione dei Compianti sul Cristo morto si diffonde soprattutto in Lombardia, a partire dal XV secolo, sulla scorta delle liturgie e delle sacre rappresentazioni che si svolgevano il Venerdì Santo. Inizialmente erano persone in carne ed ossa a rappresentare i personaggi presenti alla scena. In un secondo momento fu adoperata una statua in legno per il solo Cristo morto (talvolta deposto sulla lettiga dopo averla calata dalla croce, come nel caso di Vertova, parrocchia per la quale Andrea Fantoni realizzò nel 1725 un Cristo dalle braccia snodabili). Infine, anche gli altri personaggi furono sostituiti da statue lignee a grandezza naturale, come nel caso di Clusone, ma anche nel caso già citato di Rovetta e in quello più tardivo di Ardesio, il cui Cristo è comunque del 1711, ma le altre statue del 1782, la fase estrema della celeberrima bottega rovettese.
Di nuovo dalle pagine del Giopì in data 22 dicembre 1963 Daniele Maffeis, in arte DAMA, riporta le impressioni del critico del teatro “Mobile Lignum”, il misterioso prof. dott. Balbus: «Chi ha avuto il piacere di ammirare per la stampa, per la fotografia, meglio ancora di presenza la Deposizione di Andrea Fantoni nella chiesa dei Disciplini lassù nella piacevole cittadina di Clusone in Valle Seriana, può comprendere più facilmente quanto il musicista sia stato ripieno di incanto e di emozione e come ha trasmesso i suoi sentimenti agli ascoltatori. […] Una frase viene come interrotta al suo inizio dal dolore; espressa prima dal corno inglese, poi dal violoncello si perde e si dilaga su accordi di quarta e di sesta, uno più lontano e uno più piano dell’altro; questi accordi danno la sensazione dello stupore, dello sgomento che le statue esprimono. Un fagotto, quasi piangente, gregorianeggia la frase “guardate, o genti, se vi è un dolore uguale al mio”, palpita un clarinetto sul tremolo fitto e pianissimo dei violini e interpreta l’esclamazione dolorosa di Jacopone: “Figlio, figlio, amoroso giglio”. S’innalza poi un movimento cantabile che interpreta tutto il doloroso quadro».
La cantoria dell’organo di Castione della Presolana (1683)
Grazioso il Vecchio (1630-1693). La cantoria per l’organo di Castione è una delle prime opere realizzate dalla bottega dei Fantoni di Rovetta, iniziata già nel Quattrocento, ma decollata davvero proprio grazie a Grazioso il Vecchio, che ne ricevette la commissione nel 1683.
È un’opera di straordinaria complessità e bellezza, il cui progetto ci è pervenuto ed è conservato presso l’Archivio Fantoni di Rovetta. Grazioso disegna un unico prospetto diviso verticalmente in due metà: quella di sinistra presenta una soluzione leggermente più semplice, dominata da elementi architettonici; quella di sinistra – cui andrà la preferenza dei committenti – appare più ricca e complessa: alcune canne sono collocate su un secondo registro, ma sono le figure di angeli musicanti ad attrarre l’attenzione. Grazioso li colloca in piedi, uno su ciascuna delle sei cimase, sulle quali si innestano gli elementi che spartiscono l’ancona. Ciascuno di essi suona uno strumento musicale: chi un liuto, chi un flauto, chi una viola, chi un’arpa. Il primo progetto avrebbe inquadrato l’insieme con due colonne tortili, direttamente citate dalla basilica di San Pietro in Vaticano; il secondo, che Grazioso traduce in realtà, le sostituisce con due telamoni che reggono con un braccio i capitelli. Anche sulle volute del timpano spezzato la committenza sceglie che invece di allegorie teologiche, facciano invece capolino altri due angeli musicanti, che affiancano la statua equestre di Sant’Alessandro, titolare della chiesa e patrono della comunità. Alle estremità stanno, sia nel progetto che nella realtà, le statue in grandezza naturale di san Pietro e di san Paolo, mentre i lacunari rimasti vuoti nel disegno, nella realtà sono occupati da splendidi altorilievi con diverse scene: l’Adorazione dei pastori, l’Adorazione dei Magi, la Presentazione al Tempio e la Caduta degli angeli ribelli. Tutti questi angeli con i loro strumenti fanno della cantoria un vero e proprio inno alla musica che si sarebbe irradiata dalle canne dell’organo cui faceva da cornice e da cassa di risonanza.
Nel medesimo articolo citato poc’anzi, Daniele Maffeis, in arte DAMA, prosegue, sempre citando il critico Balbus: «Se da Clusone si prosegue per una decina di chilometri, si giunge al paese spazioso e ameno di Castione della Presolana. Chi entra nella chiesa che domina tutta la vallata e sale sulla cantoria dove Andrea Fantoni [in realtà Grazioso il Vecchio] ha costruito l’organo, capisce appieno quanto il musicista ha goduto suonando l’organo in una solennità religiosa. […] Tutti questi varietà di Alleluja vogliono descrivere l’apparizione di angioletti musicanti che aumentano sempre più si fissa lo sguardo. Uno sbuca col flauto tra una canna e l’altra, un secondo colla trombetta fra un intarsio e una colonnetta… […] Sembrerà allora un grido osannante di popolo orante e credente».
Franz Werfel (Praga, 10 settembre 1890 – Los Angeles, 1954), Il canto di Bernadette (1941).
Werfel, scrittore e drammaturgo di origine ebraica, visse tra Praga, dove nacque, Vienna, dove si trasferì dopo la Prima Guerra Mondiale e gli Stati Uniti, dove fuggì all’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1929 sposò Alma Schnider, vedova del compositore Gustav Mahler. La sua fama letteraria è principalmente legata all’opera I quaranta giorni di Mussa Dagh, dedicata a narrare il genocidio del popolo armeno ad opera dei Turchi. Nel 1941, per adempiere a un voto fatto proprio a Lourdes nel 1940 mentre stava fuggendo alla persecuzione nazista, Werfel scrisse il romanzo Il canto di Bernadette (Das Lied von Bernadette), romanzo dedicato a narrare la vita della piccola santa francese, per la quale – come del resto per il Cattolicesimo – nutriva grande simpatia. Un romanzo strutturato in cinque parti di dieci capitoli ciascuno, proprio come la preghiera del rosario, dove l’autore narra la vita di Bernadette dalla prima apparizione (11 febbraio 1858) al giorno della morte della santa (16 aprile 1879). Con un’appendice sulla canonizzazione (8 dicembre 1933).
Il romanzo ebbe un enorme successo, venne tradotto in 23 lingue, compreso l’italiano nel 1946. Dal romanzo il regista americano Henry King (uno dei trentasei fondatori dell’Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, 1927, che nel 1929 istituì il Premio Oscar) trasse il celeberrimo film Bernadette uscito nel 1943 che valse alla protagonista Jennifer Jones il premio Oscar nel 1944.